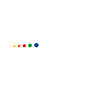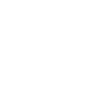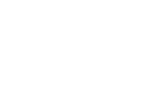Lo Sposalizio della Vergine

di Raffaello Sanzio
28 gennaio 2016, ore 21 Sala del Maggior Consiglio
Cristina Acidini – Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze
Presidente dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze
Ha compiuto mezzo millennio, ma lo Sposalizio della Vergine di Raffaello nella Pinacoteca milanese di Brera non ha mai smesso di stupire e d’incantare, tanto che si fatica a credere che un tale maturo capolavoro fosse dipinto da un ventenne. Ma Raffaello, figlio (e a nove anni orfano) del pittore di corte di Urbino Giovanni Santi, da vero enfant prodige si era formato presto, nella bottega del padre e soprattutto nel Palazzo Ducale dei Montefeltro, dove l’architettura e le arti dei massimi maestri dell’Italia centrale, da Luca Della Robbia ai Laurana, da Paolo Uccello a Piero della Francesca, si univano creando un vertice del Rinascimento umanistico. Oltre alla ricchezza dei linguaggi pittorici, compreso il fiammingo nei dipinti dello Studiolo del Duca, nella cultura urbinate si studiavano l’ottica e la prospettiva.
Nel 1504 Raffaello firmava lo Sposalizio, per la cappella di San Giuseppe della famiglia Albizzini, nella chiesa di San Francesco a Città di Castello. Nella città Raffaello, con Evangelista da Pian di Meleto, si era già rivelato ”magister” consegnando nel 1501 la Pala del beato Niccolò da Tolentino.
Certo nel progettare lo Sposalizio ebbe in mente la pala col medesimo soggetto, appena dipinta a Perugia dal collega anziano Pietro Perugino (oggi a Caen): ma nel suo quadro, assai più piccolo, Raffaello rivisitò quella composizione, rinnovandola con un disegno raffinato e una tavolozza di toni morbidi e luminosi.
Il matrimonio di Maria e Giuseppe è il soggetto, colto nell’attimo più emozionante, quando lo sposo avvicina l’anello alla mano tesa della sposa. E’ però il tempio a pianta centrale il cardine visivo e il protagonista simbolico della scena. Raffaello ce lo presenta innalzato su una piattaforma di gradini, verso cui convergono in fuga prospettica i riquadri color terracotta e le corsie bianche della pavimentazione. Ha l’insolito perimetro di sedici lati, una sorta di circonferenza sfaccettata, che tende alla perfezione ideale del cerchio senza raggiungerla. Il porticato ad archi su colonne ioniche, la cupola sull’alto tamburo finestrato, gli eleganti contrafforti a volute ne fanno un’architettura cesellata e preziosa, che idealmente rispecchia in pittura i pensieri che Bramante, urbinate anche lui, stava coltivando a Roma in quegli anni per la costruzione del Tempietto circolare di San Pietro in Montorio.
Con le porte in asse aperte sul sereno paesaggio campestre, la chiesa di Raffaello (che reca la sua firma) è la cerniera dell’unione cosmica fra vicino e lontano, alto e basso, visibile e invisibile. Lì la natura creata dalla divinità confina con l’architettura costruita; lì la città di Dio, che s’innalza oltre il cielo fisico, s’incontra con la città dell’Uomo, che dispiega sulla terra le sue civilissime piazze e i suoi nobili edifici. Pochi dipinti rinascimentali trasmettono un paragonabile senso di fiducia nella capacità umana, di tenere in armonioso equilibrio ogni componente del Creato, nel segno di una cultura umanistica intrisa di fede religiosa.
E quell’equilibrio si ritrova nei due gruppi in primo piano, uniti dalla figura centrale dell’officiante. Simmetriche ma animate da sottili variazioni, le figure si atteggiano secondo l’espressione di sentimenti pacati e di ruoli ben noti. La Vergine s’inclina in segno di pia accettazione, Giuseppe si protende nell’atto misurato e responsabile, il sacerdote è chino verso i due sposi e, con la torsione del corpo, compostamente partecipe. Tra gli astanti spicca il pretendente deluso, che spezza sul ginocchio la verga secca, mentre Giuseppe inalbera la sua, miracolosamente fiorita secondo la leggenda. Uomini e donne non formano schiere rettilinee bensì due ali lievemente ricurve, disegnando nello spazio una sorta di vivente esedra concava, controcanto alla parete ricurva del tempio esadecagonale. Tra il primo piano e il tempio, piccoli in lontananza, si muovono e conversano i passanti, i devoti, un mendicante: figure rarefatte che, al di fuori di ogni naturalismo, simboleggiano un’ideale comunità cittadina, dove gli abbienti e gli indigenti si ritrovano in piazza.
Non una nuvola percorre il cielo terso. Una luce dolcemente meridiana, proveniente da destra, pervade l’aria cristallina suscitando lievi ombre portate e modulando i pastosi chiaroscuri delle tinte ben distribuite: i rossi-arancio, i verdi scuri, i bruni violacei delle vesti, tra cui risalta il manto giallo di Giuseppe, sulla griglia bicroma della piazza, contro la mole dorata del tempio dalla cupola scura.
Il quadro rimase poco meno di tre secoli sul suo altare. Tolto nel 1798 e donato al generale napoleonico Giuseppe Lechi, che era giunto a capo dell’esercito francese per liberare Città di Castello dagli Stati Pontifici e proclamare una Repubblica, dopo alcuni passaggi di proprietà pervenne nel 1806 alla Pinacoteca di Brera, dove tuttora si ammira.
rassegna I capolavori raccontati